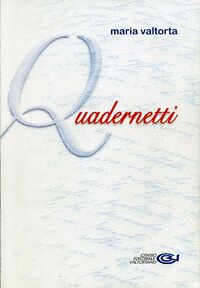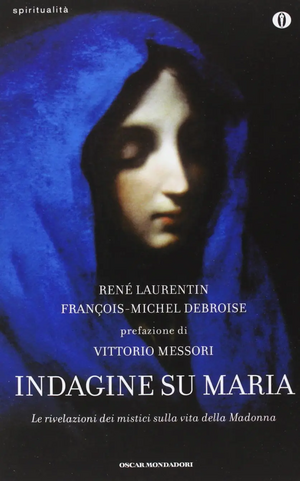Evangelisti
Nella Sacra Bibbia, i Vangeli sono la parte del Nuovo Testamento dove si narra la Vita di Gesù Cristo, dalla sua Incarnazione fino alla Resurrezione e Ascensione al Cielo. Sono costituiti da quattro racconti tra loro convergenti, i cui autori, considerati ispirati dallo Spirito Santo, hanno trasmesso la Parola di Dio agli uomini.
Tra i quattro evangelisti, due sono tradizionalmente ritenuti testimoni diretti (Matteo e Giovanni) in quanto Apostoli, mentre gli altri due sono considerati testimoni indiretti (Marco e Luca). Secondo la dottrina cristiana, non può essere riconosciuto alcun altro Vangelo che si discosti da quello rivelato.
Gli evangelisti nell’Opera principale di Maria Valtorta
Matteo (il cui simbolo è un uomo alato)
Secondo l’opinione comunemente accolta, il Vangelo secondo Matteo è finalizzato a dimostrare che Gesù è il Messia e a presentare il suo insegnamento attraverso grandi discorsi. Questo testo si distingue dal Vangelo di Marco, che conserva invece tratti di maggiore spontaneità e vivacità narrativa, ma come questo (e come il Vangelo di Luca) fa parte dei tre vangeli definiti sinottici[1].
Tre caratteristiche avrebbero predisposto l'Apostolo Matteo al suo futuro ruolo di evangelista: la memoria, l’eloquenza e la cultura.
- La memoria: secondo L’Evangelo come mi è stato rivelato, Matteo stesso avrebbe affermato di possedere un’ottima memoria, sviluppata durante il suo lavoro di esattore, grazie alla quale poteva conservare e trasmettere fedelmente i ricordi degli insegnamenti e degli eventi[2].
«Io voglio ricordare tutto questo. Ma lo potrò?», dice Pietro.
«Sta’ buono, Simone. Domani mi faccio ripetere tutto dai pastori. Con pace. Nel frutteto. Uno, due, tre volte se occorre. Io ho buona memoria, esercitata al mio banco, e ricorderò per tutti. Quando vorrai ti potrò ripetere tutto. Non tenevo neppure le note a Cafarnao, eppure…», [dice Matteo]. (EMV 136.11)
- L’eloquenza: che avrebbe conferito al suo Vangelo uno stile letterario persuasivo[3]:
«Matteo… eh! lui va bene! Usa l’antica sapienza per pelare al suo banco di gabella, per forzare gli altri a dire: “Hai ragione”» [dice di lui Simon Pietro]. (EMV 132.7)
- La cultura: che gli avrebbe permesso di annotare direttamente i discorsi di Gesù, a differenza di altri apostoli[4]:
[Scrive Maria Valtorta:] «Si rassicura dopo avere parlato con Pietro e va a stuzzicare Matteo, che scrive quietamente su un angolo del tavolo». (EMV 531.18)
È considerato il primo a mettere per iscritto un Vangelo[5], seppur quindici anni dopo gli avvenimenti:
Dice Gesù [a Maria Valtorta]: «Ma vi indicherò, a suo tempo, come distribuire gli episodi dei tre anni di vita pubblica. L’ordine dei Vangeli è buono, ma non perfetto come ordine cronologico. Un osservatore attento lo nota. Colui che avrebbe potuto dare l’esatto ordine dei fatti, per esser stato meco dall’inizio della evangelizzazione alla mia ascesa, non lo ha fatto, perché Giovanni, figlio vero della Luce, si è occupato e preoccupato di far rifulgere la Luce attraverso la sua veste di Carne agli occhi degli eretici, che impugnavano la verità della Divinità chiusa in carne umana. Il Vangelo sublime di Giovanni ha raggiunto il suo scopo soprannaturale, ma la cronaca della mia vita pubblica non ne ha avuto aiuto. Gli altri tre evangelisti mostrano uguaglianze fra loro, come fatti, ma ne alterano l’ordine di tempo, perché di tre uno solo era stato presente a quasi tutta la mia vita pubblica: Matteo, e non l’aveva scritta che quindici anni dopo, mentre gli altri li scrissero più oltre ancora, e per averne udito il racconto da mia Madre, da Pietro, da altri apostoli e discepoli». (EMV 468.1)
Secondo l’ipotesi della critica biblica, la redazione del testo del Vangelo di Matteo, avrebbe fatto ricorso anche a una raccolta di detti di Gesù denominata “fonte Q”[6], oggi perduta, che avrebbe contenuto i logia, cioè le parole del Maestro, utilizzate poi da diversi evangelisti.
Nell'Opera di Maria Valtorta, oltre a Matteo, viene menzionato anche Giovanni di Endor come annotatore delle parole di Gesù nel periodo in cui lo seguì; tali scritti sarebbero stati in seguito affidati a Marziam, il figlio adottivo di Pietro.
Marco di Giona (il cui simbolo è un leone)
Il Vangelo secondo Marco è tradizionalmente considerato legato alla predicazione dell'Apostolo Pietro, il pescatore di Galilea che diventerà il primo pontefice della Chiesa. Si caratterizza per uno stile essenziale, meno ricco di discorsi rispetto ad altri Vangeli, più semplice, talvolta persino rude, ma al tempo stesso vivace e spontaneo.
Queste caratteristiche rifletterebbero i diversi tratti del temperamento di San Pietro. Secondo alcune tradizioni, vi si riconoscerebbe anche l’influenza di Giovanni di Endor, un discepolo convertito e colto, che avrebbe preso appunti quotidiani durante il periodo in cui seguì Gesù. Tali note sarebbero poi state destinate a Marziam, figlio adottivo di Pietro, che in seguito, con il nome di Marziale, avrebbe accompagnato Pietro a Roma e poi inviato a evangelizzare la Gallia.
Riguardo alla stessa figura di Marco, restano aperti alcuni interrogativi, una delle ipotesi tradizionali lo identifica con Marco, il figlio di Giona e di Maria, i custodi della casa del Getsemani di proprietà di Lazzaro. Alcuni indizi, come la presenza di un giovane alla cattura di Gesù nel Getsemani, che lascia la veste a chi lo voleva afferrare e fugge nudo per non essere preso (raccontata soltanto nel Vangelo di Marco[7]) stanno ad indicare che la sua abitazione doveva trovarsi lì vicino e che lui era, probabilmente, il futuro evangelista.
Maria Valtorta non fa menzione del fatto che si tratti proprio dell’evangelista, però ci fornisce alcuni indizi, tra i quali il fatto che Marco figlio di Giona, dopo l'Ascensione del Signore e la Pentecoste, diventa un discepolo del Signore[8]:
Lazzaro la interrompe: «È già fatto, o Benedetta! Abbiamo già provveduto. Marco, figlio di Giona, è ora tra i discepoli. Maria, sua madre, e Giona, suo padre, già sono a Betania». (EMV 642.4)
Anche negli Atti degli Apostoli, nell'episodio della liberazione miracolosa di Pietro dalla prigione, vi è un riferimento esplicito su di lui che viene indicato come il figlio di Maria[9]:
«Dopo aver riflettuto, [Pietro] si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, detto Marco, dove molti erano riuniti e pregavano». (At 12,12)
Maria, moglie di Giona, probabilmente, è la stessa persona citata negli Atti degli Apostoli come la madre di Marco. La sua casa, prossima a Gerusalemme, era un luogo di preghiera e di riunione dei discepoli. Vi trova rifugio anche Pietro, appena liberato dall’angelo. La casa viene poi donata alla Beata Vergine Maria dove, insieme all'apostolo Giovanni si ritira in preghiera e in solitudine fino alla sua Assunzione in Cielo.
Luca (il cui simbolo è un bove)
Tra i quattro evangelisti, Luca è considerato colui che ha svolto il lavoro più accurato di indagine e di redazione storica. Alcuni episodi riportati nel Vangelo secondo Luca, in particolare quelli legati all’infanzia di Gesù, avrebbero potuto essere conosciuti soltanto attraverso la testimonianza diretta della Beata Vergine Maria.
Ma le sue fonti non si limitarono tuttavia solo a questo importante contributo. In diversi casi, fu lo stesso Gesù a raccontare ai suoi apostoli gli episodi della propria Vita, come la tentazione nel deserto.
Anche i pastori presenti alla Natività avrebbero tramandato i loro ricordi, confluiti poi nella narrazione evangelica. Si può trovare un esempio nell'Opera di Maria valtorta quando il Signore, nel Primo anno della Vita pubblica[10], si reca sui monti del Libano per rivedere i pastori Beniamino e Daniele[11]:
[Dice Daniele:] «Te le ricordi quelle parole anche tu, Beniamino».
«Sì. Te le posso ridire, Signore. Perché quanto Ella ci disse, nei mesi che la potemmo udire, è scritto qui (e si batte il petto)». (EMV 103.5)
Giovanni di Zebedeo (il cui simbolo è un'aquila)
Ciò che distingue il Vangelo secondo Giovanni dagli altri tre (detti sinottici per la loro concordanza) è una più profonda penetrazione nel mistero di Cristo. Giovanni arricchisce questa prospettiva con una notevole profondità di pensiero e una grande sensibilità narrativa.
La stretta vicinanza spirituale dell’apostolo a Gesù, unita al fatto di essere stato un testimone diretto di tutti gli avvenimenti (unico tra i Dodici in questa condizione), gli consente di riferire con intimità fatti e gesti che gli altri non poterono trasmettere.
La sua formazione ebraica e il suo amore per Gesù avrebbero favorito una memoria eccezionale, tale da permettergli di restituire integralmente e parola per parola i discorsi del Maestro.
Nell’opera di Maria Valtorta, Gesù parla del significato dei Vangeli, e attribuisce a quello giovanneo un ruolo speciale di testimonianza: Giovanni sarà la luce del Cristo fino alla fine dei tempi[12]:
[Dice Gesù a San Giovanni:] «Ebbene Io ti dico che tu mi servirai sino alla nuova mia venuta, a quella finale. Molte cose si inaridiranno prima dell’ultimo tempo, così come fiumi che si disseccano e, da bel corso d’acqua azzurra e salutare, divengono terriccio polveroso e pietroni aridi. Ma tu sarai ancora fiume suonante la mia parola e riflettente la mia luce. Sarai la suprema luce che resta a ricordare Cristo. Perché sarai luce tutta spirituale, e gli ultimi tempi saranno lotta di tenebre contro luce, di carne contro spirito. Quelli che sapranno perseverare nella fede troveranno forza, speranza, conforto in ciò che tu lascerai dopo di te, e che sarà ancora te… e che soprattutto sarà ancora Me, perché Io e te ci amiamo, e dove tu sei Io sono, e dove Io sono tu sei. Ho promesso a Pietro che la Chiesa, che avrà a capo e a base la mia Pietra, non sarà scardinata dall’Inferno nei suoi ripetuti e sempre più feroci assalti, ma ora ti dico che ciò che sarà ancora Io, e che tu lascerai a luce per chi cerca la Luce, non sarà distrutto nonostante che l’Inferno, con ogni maniera, cercherà di annullarlo. Anzi, più! Anche coloro che crederanno in Me imperfettamente, perché pur accogliendo Me non accoglieranno il mio Pietro, saranno sempre accorrenti al tuo faro come navicelle senza pilota e senza bussola, che si dirigono fra la loro tempesta verso una luce, perché luce vuol dire ancora salvezza». (EMV 508.2)
Gli Evangelisti nelle altre opere di Maria Valtorta
I Quaderni del 1943
28 giugno:
Dice Gesù: «[…] Adesso ti spiego due punti del Vangelo. Uno è di Matteo e uno di Luca. In realtà sono un’unica parabola, ma espressa con qualche differenza. Che nei miei evangelisti si trovino queste differenze non deve fare stupore. Quando scrivevano quelle pagine erano ancora uomini. Già eletti, ma non ancora glorificati. Perciò potevano commettere sviste ed errori, di forma, non di sostanza. Solo nella gloria di Dio non si erra più. Ma per raggiungerla essi dovevano ancora molto lottare e soffrire.
Soltanto uno degli evangelisti è di una esattezza fonografica nel riportare quanto Io dissi. Ma quello era il puro e l’amoroso. Rifletti su ciò. La purezza e la carità sono tanto potenti che permettono di capire, ricordare, trasmettere, senza l’errore neppure d’una virgola e di una riflessione, la parola mia. Giovanni era un’anima su cui l’Amore scriveva le sue parole, e lo poteva fare perché l’Amore non si posa e non ha contatto altro che coi puri di cuore, e Giovanni era un’anima verginale, pura come quella d’un pargolo […]». (28 giugno 1943)
I Quaderni del 1945-1950
30 settembre 1947:
Dice Gesù […]: «Le mie parole, poi, nelle versioni degli evangelisti, dei quali due soli furono apostoli — e se ben si osserva sono i due Vangeli più rispecchianti Me, perché quello di Luca, stilisticamente buono, può dirsi più il Vangelo di mia Madre e della mia Infanzia, delle quali narra diffusamente particolari che gli altri non narrano, che non Vangelo della mia vita pubblica, essendo più eco degli altri che luce nuova come è quello di Giovanni, il perfetto evangelista della Luce che è il Cristo Dio-Uomo — le versioni, dicevo, delle mie parole, dagli evangelisti furono molto ridotte, sino ad essere ridotte scheletriche: più un accenno che una versione. Cosa che le priva della forma stilistica che Io avevo dato ad esse.
Il Maestro è in Matteo (vedere discorso della Montagna, le istruzioni agli apostoli, l’elogio al Battista e il resto di questo capitolo, il primo episodio del 15° capitolo e il segno del Cielo, e il divorzio, 19° cap., e i tre cap. 22-23-24). Il Maestro è soprattutto nel luminoso Vangelo di Giovanni, l’Apostolo innamorato, fuso nella carità al suo Cristo-Luce. Confrontate quanto disvela della potenza del Cristo oratore questo Vangelo con quanto ne disvela la esiguità essenziale del Vangelo di Marco, esatto negli episodi sentiti da Pietro, ma ridotto ad un minimo, e vedrete se Io, il Verbo, usavo solo uno stile molto umile o se non sfolgorava sovente in Me la potenza della perfetta Parola. Sì, in Giovanni Essa brilla, per quanto molto ridotta in pochi episodi.
Ora, se al piccolo Giovanni Io ho voluto dare un aumento di conoscenza di Me e del mio insegnamento, perché dovrebbe questo farvi increduli e duri? Aprite, aprite intelletto e cuore, e beneditemi per quanto vi ho dato». (30 settembre 1947)
15 agosto 1949 Sera:
Mi dice Gesù: «Solo la Madre mia seppe tutto di Me, sia del mio tempo di Figlio a Nazaret, che di Maestro e Redentore, che di Risorto glorioso. Perché, e per mia parola e per disposizione divina, Maria tutto sapeva e partecipava di Me: fatiche, dolori, gioie e trionfi. Maria sola. Gli evangelisti ed apostoli seppero in parte di questa o quella parte della mia vita. E molto, quasi tutto ignorarono di mia Madre.
Ma tu, mia piccola Maria, mio piccolo Giovanni, tu, tu sola sai tutto di Me e di Maria. Tu hai vissuto la nostra vita, al fianco nostro. Tu hai respirato l’aria della nostra casa, della casa di Gioacchino e poi di Maria, della nostra Nazaret, della nostra Palestina tutta. Tu hai sentito l’odore del pane sfornato da Maria, delle tele da Lei lavate, del suo Corpo verginale e del mio. Tu hai sentito l’odore dei balsami della Maddalena, e della putredine del risorto Lazzaro, l’odore dell’agnello e del vino della Cena pasquale e quello del mio Sangue sparso nella Passione. Tu hai contato i nostri respiri e voci e sguardi, atti, lezioni, miracoli.
Più del grande Giovanni tu sai. O mia crocifissa adoratrice, questo ti ho voluto dare per il tuo lungo patire: la perfetta, completa conoscenza di Noi, quali Santi e Dottori non l’ebbero. Ma i tempi urgono. Solo una conoscenza ampia di Me può salvare […]». (15 agosto 1949)
Commento all’Apocalisse: Capitolo I :
E dato che l’infinita Misericordia, per pietà dei miseri uomini travolti dalla bufera di sangue, di fuoco, di persecuzione, di morte, farà risplendere sul mare di sangue e d’orrore la pura Stella del Mare, Maria, che sarà la precorritrice del Cristo nella sua ultima venuta, questi nuovi evangelizzatori evangelizzeranno Maria, in verità troppo lasciata in ombra dagli Evangelisti e dagli Apostoli e Discepoli tutti, mentre una più vasta conoscenza di Lei avrebbe ammaestrato tanti, impedendo tante cadute. Perché Ella è Corredentrice e Maestra. Maestra di vita pura, umile, fedele, prudente, pietosa, pia, nella casa e tra le genti del suo tempo. Maestra sempre, nei secoli, degna d’esser tanto più conosciuta più il mondo scende verso il fango e la tenebra, per esser tanto più imitata onde riportare il mondo verso ciò che non è tenebra e fango. (I Quaderni del 1945-1950, pagine 520-521)
Commento all’Apocalisse: Capitolo II
Ma se gli antichi Profeti non videro che l’Uomo Dio, alcuni, altri videro l’Uomo Dio portato sul suo trono dai suoi principali confessori. I quattro evangelisti dall’aspetto raffigurante la loro natura spirituale. Matteo: l’uomo, tutto uomo nel suo passato e uomo nel descrivere il Figlio dell’Uomo; Marco: il leone, nel predicare il Cristo tra i pagani più ancora che nel descrivere il tempo del Cristo nel suo Vangelo, nel quale però, da leone, amò far risaltare più la figura del divino Taumaturgo che dell’Uomo-Messia come aveva fatto Matteo. E ciò allo scopo di sbalordire e conquistare, attraverso allo sbalordimento, i pagani, sempre sedotti da quanto aveva aspetto di prodigio.
Luca, paziente e forte come il bove nel completare, con ricerche pazienti anche sull’antefatto del vero e proprio lavoro apostolico del Cristo e dei suoi seguaci, tutta l’opera di Dio per la salute dell’umanità. Perché quest’opera di amore infinito ha avuto principio con il Concepimento immacolato di Maria, con la pienezza della Grazia a Lei concessa, con la continua comunione di Maria col suo Signore che, dopo averla creata, da Padre, con una perfezione unica tra tutti i corpi di nati da uomo e donna, come sua Figlia amatissima, la colmò poi della sua Luce: il Verbo che le si era rivelato nelle divine ed intime lezioni per cui Ella fu Sede della Sapienza sin dai più teneri anni, mentre lo Spirito Santo, eterno Amatore dei Puri, riversava in Lei i fuochi della sua carità perfettissima e, facendo di Lei un altare e un’arca più santa e diletta di quelli del Tempio, in Lei prendeva il suo riposo e raggiava in tutto lo splendore della sua Gloria. (I Quaderni del 1945-1950, pagine 561-562)
[…] E ben può dirsi che chi vuol conoscere Maria, troppo poco rivelata dagli Evangelisti e negli Atti degli Apostoli, deve guardare il Figlio suo che da Lei, e da Lei sola, ha preso tutto, meno che la sua Natura divina di Primogenito del Padre e suo Unigenito. (I Quaderni del 1945-1950, pagina 565)
[…] Giovanni, il quarto Evangelista, è l’Aquila. È dell’aquila il volo alto, potente e solitario, e la capacità di fissare il sole. In Giovanni evangelista vi è la nobiltà dell’uccello regale, il volo potente, e il potere di fissare il divino Sole, Gesù: Luce del mondo, Luce del Cielo, Luce di Dio, infinito Splendore, il potersi innalzare ad altezze soprannaturali alle quali nessun altro evangelista si innalzò e, così innalzandosi, il poter penetrare il mistero, e la verità, e la dottrina, e tutto dell’Uomo che era Dio.
Spaziando come aquila regale ben alto sopra le cose della Terra e dell’umanità, egli vide il Cristo nella sua vera Natura di Verbo di Dio. Più che il Taumaturgo e il Martire, Giovanni ci presenta “il Maestro”. L’unico perfettissimo Maestro che ebbe il mondo. Il Maestro-Dio, la Sapienza fattasi carne e verbale maestra agli uomini, il Verbo, o Parola del Padre, ossia la Parola che rende sensibili agli uomini i pensieri del Padre suo, la Luce venuta ad illuminare le tenebre e a fugare le penombre.
Le verità più sublimi, più soavi, più profonde, e le verità più amare, sono tutte sinceramente dette nel vangelo di Giovanni, che col suo occhio d’aquila e il suo innalzarsi con lo spirito seguendo lo spirito del Maestro ha, dall’alto, visto le supreme grandezze e le supreme bassezze, misurato l’ampiezza dell’amore di Cristo e dell’odio del mondo giudaico a Cristo; la lotta fra la Luce e le tenebre, delle troppe “tenebre”, ossia dei troppi nemici del Maestro suo, tra i quali era persino un discepolo e apostolo che Giovanni chiaramente, in questo suo vangelo della Verità e della Luce, chiama col suo vero nome, con uno dei suoi veri nomi: “ladro”; ha visto le congiure sotterranee, i tranelli sottili, usati per rendere inviso il Cristo ai dominatori romani ed ebraici e ai “piccoli” che formavano il gregge dei fedeli al Cristo. E tutte le nota e le rende note, mostrando Gesù nella sua santità sublime, non solo di Dio ma anche di Uomo. (I Quaderni del 1945-1950, pagine 565-566)
[…] Nessuno conobbe il Cristo intimo quanto Giovanni. Tutte le perfezioni del Cristo gli furono note. Penetrò nel suo mistero e nell’oceano delle sue virtù, misurandone veramente l’altezza, la larghezza e la profondità di questo Tempio vivente non fatto da mano d’uomo e che invano gli uomini cercavano di distruggere. E tutte, a distanza di decenni, le scrisse e descrisse, lasciando il Vangelo più perfetto in veridicità storica, più potente in dottrina, più luminoso di luci sapienziali e caritative, più fedele nella descrizione degli episodi e caratteri, capace di superare le restrizioni mentali degli ebrei e descrivere anche quanto gli altri evangelisti non avevano osato dire: la samaritana, l’ufficiale regio, lo scandalo e fuga e rivolta contro il Maestro dei discepoli dopo il discorso del Pane del Cielo, e l’adultera, e le aperte dispute con i Giudei, Farisei, Scribi e Dottori, e il suo rifugiarsi in Samaria ad Efraim, e i suoi contatti coi Gentili, e la verità su Giuda “che era ladro”, e altre cose ancora.
Più che maturo d’anni, perché longevo quando scrisse il suo vangelo, ma perennemente giovane perché puro, ma sempre ugualmente e ardentemente amoroso del Cristo, perché nessun altro amore umano aveva sottratto fiamme alla sua carità per l’Amato, Giovanni, l’amorosa aquila di Cristo, ci ha rivelato il Cristo, con una potenza superiore ad ogni altra, inferiore solo a quella del Cristo stesso, la quale era infinita perché potenza di Dio, nel rivelarci il Padre suo. (I Quaderni del 1945-1950, pagine 567-568)
[…] A questo amante ardente, che portato dall’amore salì con lo spirito e l’intelletto a zone eccelse e penetrò nei misteri più alti come nessun altro apostolo ed evangelista, contrapponiamo l’uomo: Matteo. Giovanni tutto spirito, sempre più spirito; Matteo materia, tutto materia sinché il Cristo non lo convertì e fece suo. Giovanni: l’angelo in aspetto d’uomo, il serafino, anzi, che con le sue ali d’aquila saliva là dove solo a pochissimi è dato salire; Matteo: l’uomo, ancora l’uomo anche dopo la conversione che di lui, uomo peccatore, fece l’uomo di Dio, ossia un uomo rielevato al grado di creatura ragionevole e destinata all’eterna vita del Cielo. Ma sempre uomo, senza la coltura di Luca, senza la sapienza soprannaturale di Giovanni, senza la forza leonina di Marco. Nella mistica scala degli evangelisti si può mettere Matteo al primo gradino, Marco ad un quarto della scala, Luca al mezzo di essa e Giovanni sul culmine. (I Quaderni del 1945-1950, pagine 568-569)
[…] Ognuno dei quattro servì per comporre il mosaico che ci dà il vero Gesù Cristo Uomo-Dio, Salvatore, Maestro, Redentore, Vincitore della morte e del demonio, Giudice eterno e Re dei re in eterno. Per questo, nella teofania che descrive l’Apostolo Giovanni nel suo Apocalisse, i quattro, coi loro quattro diversi aspetti, fanno da base e corona al Trono dove è assiso Colui che è, che era, che ha da venire e che è l’Alfa e l’Omega, principio e fine di tutto quanto era, è, e sarà, e le loro voci, unite a quelle dei ventiquattro, ossia dei dodici principali patriarchi e dei dodici più grandi profeti, o profeti maggiori, cantano l’eterna lode a Colui che è Santissimo e Onnipotente. (I Quaderni del 1945-1950, pagine 569-570)
Quadernetti
Nel volume dei Quadernetti, che raccoglie scritti di Maria Valtorta redatti su fogli sparsi e taccuini, si trova un 'dettato' attribuito a Gesù, datato 17 ottobre 1944, in cui viene affrontata la questione del cosiddetto “quinto Vangelo”.
In questo 'dettato' viene affermato con chiarezza che i Vangeli canonici sono e restano quattro: Matteo, Marco, Luca e Giovanni. La loro autorità, riconosciuta dalla tradizione della Chiesa, è definitiva e insostituibile. Si ribadisce che la rivelazione divina si è compiuta pienamente in Cristo e che i quattro Vangeli costituiscono l’unica testimonianza evangelica autentica. Non esiste, dunque, un “quinto Vangelo” in senso canonico o dottrinale, poiché la Rivelazione è già compiuta in Cristo e trasmessa in modo completo attraverso la Sacra Scrittura e la Tradizione.
Le spiegazioni e le 'visioni' mistiche attribuite a Maria Valtorta non intendono sostituire o aggiungere nuovi contenuti ai Vangeli canonici, ma piuttosto illuminare e approfondire ciò che essi già contengono, offrendo al lettore un aiuto alla comprensione e alla meditazione. Si tratta quindi di un’opera che richiama l’attenzione sui contenuti evangelici, senza modificarne l’essenza.
In questa prospettiva, gli Scritti di Maria Valtorta si pongono come un sostegno spirituale alla lettura dei Vangeli: ne custodiscono la centralità e, al tempo stesso, li accompagnano con la luce della sua esperienza mistica.
Dice Gesù: «[…] E veniamo al così detto 5° evangelo.
I Vangeli sono quattro. Ora Io li sto illustrando per portare altri alla luce che hanno perduta o sminuita. Ma non creo un altro Vangelo. Quelli sono e quelli restano. Conosciuti nei particolari o lasciati nelle linee schematiche, quelli sono e non più». (17 ottobre 1944)
Presentazione dei quattro Vangeli nella Sacra Bibbia della CEI
Secondo la prospettiva adottata dalla traduzione CEI, i quattro Vangeli non sono semplici cronache biografiche, ma testimonianze di fede, redatte alla luce della risurrezione e della predicazione apostolica. Essi raccolgono la memoria viva delle comunità cristiane delle origini, che hanno trasmesso oralmente episodi e parole di Gesù, successivamente messi per iscritto.
I primi tre, Matteo, Marco e Luca, sono detti sinottici per la loro concordanza e per la possibilità di essere letti parallelamente. Essi furono composti tra il 50 e l’80 d.C., con l’intento di custodire fedelmente il messaggio degli apostoli e di rispondere alle necessità delle diverse comunità. Il quarto Vangelo, quello di Giovanni, presenta invece una prospettiva più teologica e riflessiva, frutto di una meditazione approfondita sul mistero di Cristo.
Tutti e quattro i Vangeli hanno in comune il fatto di essere scritti di carattere narrativo. Si tratta inoltre di narrazione storiografica. Il termine “vangeli” è riservato solamente ai quattro testi (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) totalmente incentrati sulla vita, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Il termine “vangelo” (o “evangelo”) deriva dal latino evangelium, a sua volta derivato dal greco euanghèlion. Se per noi tale parola evoca dei testi scritti, i “libri” dei vangeli, non era così in epoca neotestamentaria, quando indicava la proclamazione orale di un messaggio. Il vangelo non è dunque prima di tutto uno scritto, ma un annuncio orale, una predicazione. Nella letteratura greca non cristiana il termine indica la ricompensa data al messaggero per la buona notizia annunciata, e quindi anche la “buona notizia”, in particolare la notizia di una vittoria militare.
Vangelo secondo San Matteo
I contenuti: Il vangelo di Matteo, per la ricchezza dei suoi contenuti, ha goduto di una larga diffusione lungo tutta la storia della Chiesa. Matteo dà grande importanza all'insegnamento di Gesù. Secondo il parere di molti studiosi, questo vangelo è articolato sulla base di cinque grandi discorsi. Per il resto, Matteo segue il racconto di Marco. Il libro si apre con uno scorcio sull'infanzia di Gesù, seguito dal racconto dei fatti essenziali che precedettero il suo ministero pubblico. Le pagine conclusive si riferiscono all'evento pasquale. [...]
Le caratteristiche: In questo vangelo Gesù è presentato come colui che porta a compimento la storia e le speranze di Israele: la sua figura viene infatti collegata ai grandi personaggi dell'AT, in particolare a Mosè. Egli è il Maestro che insegna la nuova dottrina della salvezza; con la sua attività pubblica inaugura l'avvento del regno di Dio; chiamando i discepoli, dà inizio alla Chiesa, popolo di Dio; con la sua morte e risurrezione si manifesta come messia, il Figlio di Dio, annunciato dai Profeti, e ciò trova conferma nelle molte citazioni, tratte dalle Scritture ebraiche.
L'origine: La tradizione unanime della Chiesa antica attribuisce questo vangelo a Matteo, detto anche Levi, l'apostolo che Gesù chiamò al suo seguito dalla professione di pubblicano, cioè di esattore delle imposte (9,9). Con i vangeli di Marco e Luca, è uno dei tre vangeli sinottici. I destinatari immediati del vangelo di Matteo erano cristiani di origine ebraica, che probabilmente abitavano nella zona di Antiòchia di Siria. Forse un primo nucleo di questo vangelo, scritto in lingua aramaica, fu pubblicato tra il 40 e il 50 (e alcuni studiosi pensano di riconoscere in esso una fonte di Marco, altri la cosiddetta fonte Q). A noi è pervenuta soltanto una redazione greca, già conosciuta nel I sec. Per la stesura definitiva di questa redazione l'autore sembra abbia seguito da vicino soprattutto il vangelo di Marco. [13]
Vangelo secondo San Marco
I contenuti Lo scopo del vangelo di Marco è quello di affermare con chiarezza l'identità di Gesù di Nazaret, il Cristo-messia, il Figlio di Dio, riconosciuto e adorato come il Signore, crocifisso e risorto. Il testo riferisce soprattutto parole e fatti legati all'attività svolta da Gesù in Palestina, a partire dalla Galilea fino a Gerusalemme, e manca di qualsiasi riferimento alla sua infanzia. [...]
Le caratteristiche: Nel quadro generale gli episodi riferiti non sono strettamente collegati fra loro, la psicologia dei protagonisti non è approfondita, la collocazione nel tempo e nello spazio è molto schematica. Eppure ci sono aspetti particolari di grande interesse: le scene che descrivono l'ambiente palestinese sono ricche di annotazioni concrete e vivaci; Gesù si mostra, ogni volta, un personaggio che non finisce di stupire, un uomo vero e sensibile, deciso e sicuro nella parola e nei gesti, assolutamente indipendente dai maestri della legge di Mosè. Egli non ricerca popolarità, ma autenticità di rapporti; la sua vita e il suo insegnamento vogliono condurre alla fede.
L'origine: La Chiesa antica attribuisce questo vangelo a Marco, conosciuto da Pietro[14], compagno di Paolo e Bàrnaba nei loro viaggi missionari [15] e, infine, collaboratore di Pietro a Roma[16]. Secondo l'opinione oggi più comune tra gli studiosi, si può fissare la data dello scritto verso l'anno 70. Il vangelo venne composto per fedeli di origine pagana e, secondo la tradizione più antica, per i cristiani di Roma. Ad essi Marco presenta Gesù messia e Figlio di Dio, operatore di miracoli, dominatore di Satana che viene costretto a riconoscergli una superiorità divina. [17]
Vangelo secondo San Luca
I contenuti Il vangelo secondo Luca, per quanto riguarda la figura e i fatti della vita pubblica di Gesù, segue da vicino il racconto di Marco. Condivide inoltre con Matteo una serie notevole di testi legati all'insegnamento di Gesù. Luca raccoglie anche notizie del tutto nuove: oltre agli episodi circa l'infanzia di Gesù, egli presenta una vasta sezione in cui è presente molto materiale che non ha paralleli negli altri vangeli. I molti preziosi apporti di Luca sono lì collocati nello schema di un lungo viaggio verso Gerusalemme. Gerusalemme infatti sta al centro dell'opera lucana, vangelo e Atti degli Apostoli: verso di essa converge tutto il mistero di Gesù - Luca lo mette in evidenza con molteplici ritocchi - e da essa prende il via l'impegno missionario della Chiesa nascente. [...]
Le caratteristiche: Il terzo vangelo offre un contributo originale alla comprensione del mistero di Gesù: anzitutto perché lo approfondisce, riferendo nuovi episodi della sua infanzia; poi perché colloca la persona di Gesù nel contesto della storia della Chiesa. Questo libro costituisce, infatti, la prima parte di un'opera unitaria che comprende vangelo e Atti degli Apostoli, ambedue scritti con le stesse idee dominanti e il medesimo stile. Un vangelo dunque da leggersi in parallelo a quelli di Marco e di Matteo, ma anche in continuità con il libro degli Atti.
L'origine: Luca, discepolo e collaboratore di Paolo apostolo, è ricordato in alcune lettere del Nuovo Testamento[18]; antichissime fonti e studiosi di ogni tempo riconoscono in lui l'autore del terzo vangelo e degli Atti degli Apostoli. Questo fatto rende quanto mai preziosa la testimonianza di Luca e lo caratterizza a fronte di tutti gli altri scrittori del Nuovo Testamento. Destinatario della sua opera è Teòfilo[19]: in lui è invitato a riconoscersi ogni discepolo del Signore Gesù. La data di composizione del terzo vangelo è probabilmente vicina agli anni 70/80. Luca sembra aver scritto per una comunità cristiana non palestinese, che continua la predilezione di Gesù per i poveri, per i peccatori e per la vita di preghiera. [20]
Vangelo secondo San Giovanni
I contenuti Il vangelo di Giovanni narra - come gli altri vangeli - avvenimenti della vita di Gesù, a partire dall'incontro con Giovanni il Battista fino agli ultimi incontri con i discepoli (in particolare Pietro e il discepolo prediletto), dopo la sua risurrezione. Il racconto è introdotto da un prologo[21] e si conclude con l'ultima apparizione di Gesù al lago di Tiberiade[22]. Il corpo del racconto è organizzato in due parti: dalla prima Pasqua agli episodi successivi alla risurrezione di Lazzaro[23] e poi dall'ultima cena alle apparizioni del Risorto ai discepoli[24]. Nella prima parte la narrazione si snoda attorno alle feste dei Giudei e ai miracoli (o "segni") e insegnamenti di Gesù; nella seconda si assiste al passaggio dalla Pasqua dei Giudei alla Pasqua di Gesù. [...]
Le caratteristiche: Il vangelo di Giovanni coincide con quelli di Matteo, Marco e Luca (molto più simili tra loro) in punti importanti: l'inizio con il Battista, la presenza dei discepoli, l'attività taumaturgica, l'insegnamento con autorità, la condanna a morte, la crocifissione e, infine, la risurrezione di Gesù. Ma presenta anche momenti di tipica autonomia: il periodo dell'attività pubblica di Gesù dura oltre due anni e non uno solo: i suoi spostamenti dalla Galilea a Gerusalemme avvengono non una, ma più volte; i miracoli narrati sono diversi[25]; d'impostazione diversa è soprattutto l'insegnamento, che insiste sulla missione e preesistenza di Gesù e sulla sua unione con il Padre e presenta con diverso linguaggio il mistero della Chiesa e delle ultime realtà. Questa diversità è da spiegare soprattutto con la vicenda personale dello scrittore e la situazione dei lettori.
L'origine: L'autore del quarto vangelo è identificato già dalle antiche testimonianze della tradizione ecclesiastica con Giovanni, uno dei Dodici, figlio di Zebedeo e fratello di Giacomo. In questo vangelo non si incontra mai il suo nome, mentre solo in esso compare la figura del "discepolo che Gesù amava": la tradizione antica ha spiegato il fatto identificando Giovanni e il discepolo prediletto. Il vangelo sarebbe stato scritto durante la vecchiaia avanzata di questo apostolo, nella comunità cristiana di Èfeso. Oggi, per lo più, si ritiene che il processo di formazione del libro sia il risultato di un incontro, maturato attraverso un non breve travaglio, fra tradizioni risalenti alla vita di Gesù e riflessioni elaborate in un caratteristico ambiente ecclesiale, con riferimento alla personalità dell'apostolo Giovanni, quale fonte di ricordi e di un pensiero fecondo. [26]
Estratto dal volume “Indagine su Maria - Le rivelazioni dei mistici sulla vita della Madonna”
È normale che in materia di fede e di rivelazione ci siano delle differenze. È il caso del Vangelo stesso. È Parola di Dio per la Chiesa. È dunque Dio l’autore indiscusso, ma è anche non di meno l’opera di uno scrittore umano, strumento di Dio, che mantiene la sua libertà, la sua personalità, il suo carattere, la sua istruzione, le sue inclinazioni, i suoi pregi o difetti stilistici, poiché è uno strumento vivo e non una penna o una matita. È l’autore umano, e dunque libero. E Dio se ne è servito dall’interno per dare forma alla sua Parola. Si tratta più di una co-azione che di un’interazione, poiché il Creatore è causa interna e congiunta di tutto il resto.
A livello naturale, come al livello soprannaturale, in ogni azione umana, tutto è di Dio, causa prima, e tutto è dell’uomo, causa seconda, di cui Dio crea l’autentica libertà.
Questo punto è, filosoficamente e teologicamente, essenziale.
I quattro Vangeli non potrebbero essere più differenti per la scelta degli episodi: 111 pericopi[27] su 373 sono propri di un solo Vangelo (4 in Marco, 30 in Matteo, 36 in Luca, 41 in Giovanni), gli altri 262 sono comuni talvolta a tre, talvolta a due evangelisti (qualche volta a quattro, in particolare per la Passione).[28] I due Vangeli dell'infanzia (Matteo 2 e Luca 2) non hanno un solo episodio comune: nemmeno la nascita di Gesù, che Matteo non racconta neanche in sintesi. Dice soltanto, al passato: «Generato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero» (Matteo 2,1). Dice generato, non nato.[29]
Molti esegeti parlano delle loro «contraddizioni»: non ce n'è nessuna — né storica né teologica — e notevole è il loro accordo a questi due livelli, cosa che affermano «La vita autentica di Gesù», «I Vangeli dell'infanzia» e «I Vangeli del Natale»:[30] concordia discordantium[31] si sottolineava già nel Medioevo.
(Indagine su Maria di padre René Laurentin e François-Michel Debroise, Mondadori, (2012) pp. 185-186.
Note
- ↑ dal greco syn-opsis, che significa “visione d'insieme”
- ↑ EMV 136.11
- ↑ EMV 132.7
- ↑ EMV 531.18
- ↑ EMV 468.1
- ↑ dal tedesco Quelle, in italiano: “fonte”
- ↑ Mc 14,51-52
- ↑ EMV 642.4
- ↑ At 12,12
- ↑ (nel terzo periodo di 4 mesi)
- ↑ EMV 103.5
- ↑ EMV 508.2
- ↑ (Introduzione al Vangelo di Matteo - Bibbia CEI 2008)
- ↑ (At 12,12; 1Pt 5,13)
- ↑ (At 12,25; 15,37-39)
- ↑ (1Pt 5,13)
- ↑ (Introduzione al Vangelo di Marco Bibbia - CEI 2008)
- ↑ (Col 4,14; Fm 24; 2Tm 4,11)
- ↑ (Lc 1,3; At 1,1)
- ↑ (Introduzione al Vangelo di Luca Bibbia - CEI 2008)
- ↑ (Gv 1,1-18)
- ↑ (Gv 21)
- ↑ (Gv 1,19-12,50)
- ↑ (Gv 13,1-20,31)
- ↑ (a eccezione di quelli di Gv 6)
- ↑ (Introduzione al Vangelo di Giovanni Bibbia - CEI 2008)
- ↑ In genere, in un testo sacro, una pericope designa un estratto formante un'unità letteraria o un pensiero coerente.
- ↑ René Laurentin, Vie authentique de Jésus, Paris, Fayard, 1996, p. 32.
- ↑ Il testo della CEI traduce nato (NdT).
- ↑ René Laurentin, Vie authentique de Jésus, cit. Les Évangiles de l'enfance, Paris, Desclée de Brouwer, 1983 e Les Évangiles de Noël, Paris, Desclée de Brouwer, 1985
- ↑ espressione latina che intende dire che l’armonia si manifesta anche attraverso differenze o contraddizioni apparenti.